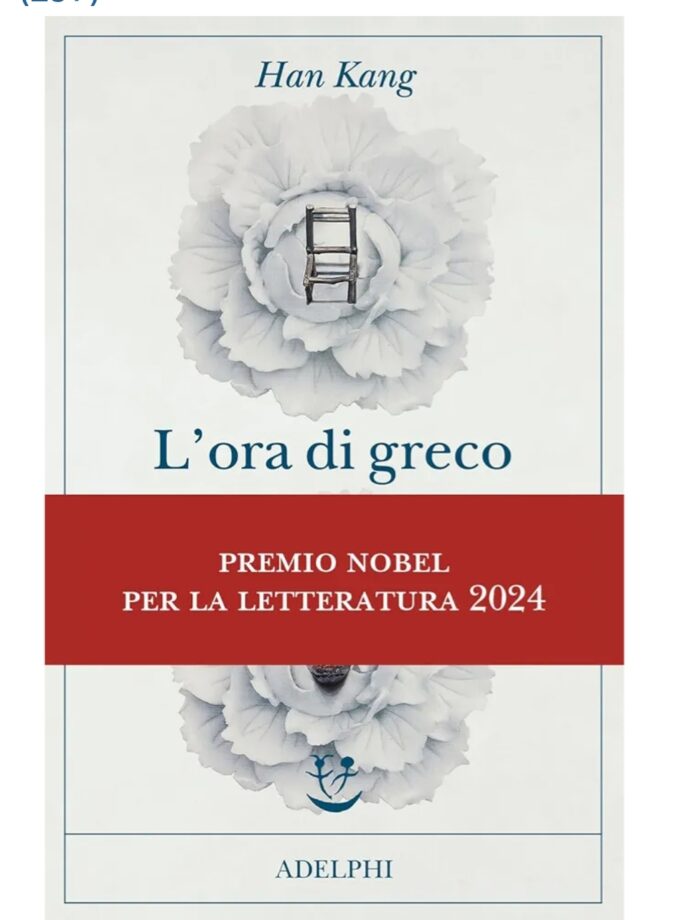“Questi due verbi significano soffrire e apprendere. Sono quasi identici, vedete? Qui Socrate ricorre a una sorta di gioco di parole per dirci che si tratta di due atti simili.”
Han Kang con “L’ora di greco” per Adelphi, colpisce ancora.
Poche volte di un libro mi rimane dentro ciò che provo leggendolo, piuttosto la trama, mi lascio trasportare dai personaggi, eppure in queste pagine a trasudare è la delicatezza.
Non conta tanto la storia tra due umani che vivono un’esperienza di privazione sensoriale, quanto ciò che in quella privazione naturale o per scelta, mettono in campo.
Han Kang esplora come una speleologa gli abissi oscuri dei traumi, ciò che lasciano dentro di noi, e se in questo libro la protagonista reagisce con il mutismo, il protagonista reagisce con la placida accettazione nel convivere con la perdita della vista.
Cosa rimane in mezzo a tutto questo? Le parole.
Le parole che assumono i connotati di un’entità umana, che restituiscono a questi due protagonisti la dignità del dolore.
Non c’è rabbia, non c’è sopraffazione, ma candido amore per tutto ciò che fa paura e per quella bellezza che tanto viene decantata ma può passare solo attraverso la conquista delle “cose difficili”, perché sono le più nobili.
Esiste un silenzio che riesce ad essere visto anche da occhi ciechi, a generare l’armonia è la forza di chi attraverso la sofferenza ha appreso il senso della sua esistenza.
Che bella compagnia Han Kang. Che bella poesia