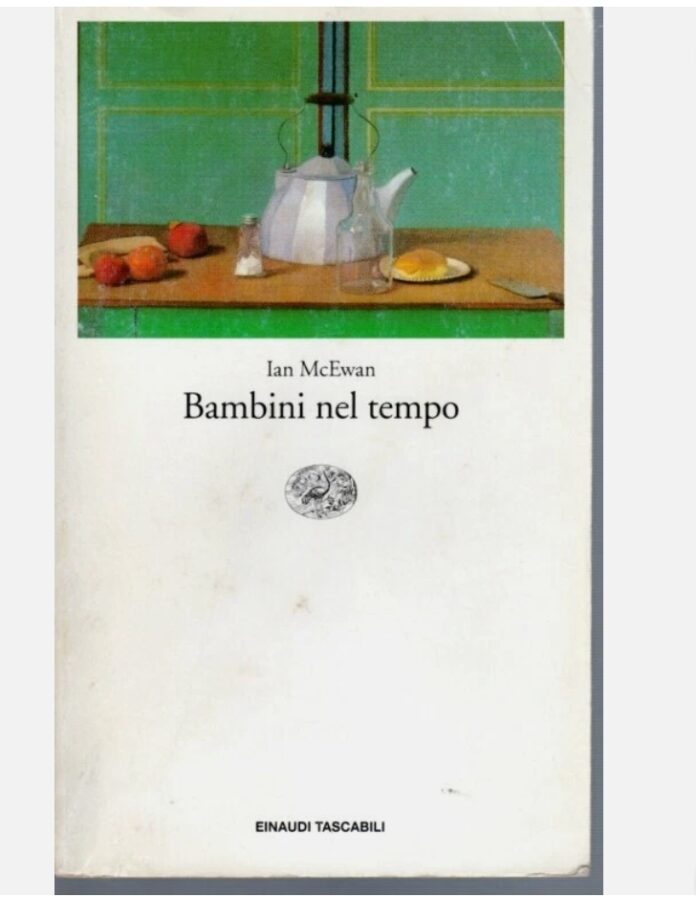Cosa ci può essere di più doloroso della perdita di un figlio? E cosa cosa puó farti sentire tanto fragile come il rapimento di un figlio? Quando era con il papà, mentre facevano la spesa al supermarket.
McEwan in “Bambini nel tempo”(Einaudi) non indaga minuziosamente solo le piaghe di un sentimento cupo, spietato, impietoso, capace di sovvertire ogni regola temporale, personale e soprattutto ogni equilibrio familiare, no, lui indaga anche la superficie politica e sociale che Stephen, il protagonista e Julie la moglie, vivono.
Lo fa come faceva Virginia Wolf, scavando caverne dietro i personaggi, per conferirgli umanità, spessore, verità.
Il punto è che poi ci si ritrova catapultati dentro quel tempo che per Stephen sembra essersi cristallizzato, cullato dalla depressione, da sentimenti che lo fanno sentire protetto, incapace di indagarsi e di indagare cosa intorno a lui si sta lentamente e sorprendentemente mutando: Julie.
Una donna capace di stravolgere le regole del dolore conferendogli una nuova copertina, attraversarlo dunque e trasformarlo in qualcosa di buono.
Torna il tempo, perché c’è sempre un tempo per tutto, per restare e per andare, per fermarsi e per camminare, per accasciarsi con le gambe spezzate e per ricostruirsi.
Siamo tutti parte di questo tempo, ognuno col proprio bagaglio, ognuno come meglio può.
A fare da sfondo è la scrittura, compagna di viaggio di Stephen, sorella, amica e consolatrice, mi ha ricordato Stoner, quando il mondo crollava in mille pezzi lui, come Stephen aveva come ancora di salvezza la letteratura.
Stephen scrive per i bambini, evocativo, perché attraverso i loro occhi il mondo appare inspiegabilmente più interessante e il tempo è sempre presente.
“I figli sono la nostra più grande risorsa, più del petrolio, più dell’energia nucleare.”
In poche parole, “Bambini nel tempo” il libro di Ian McEwan
*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita e l’indirizzo https://inliberauscita.it
____________________________________________________
Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva
Redazione redazione@inliberauscita.it
Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it